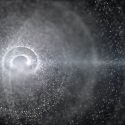Cosmologia Classica

IL MODELLO SCIENTIFICO
Due sono gli obiettivi che si prefigge la scienza: da un lato la ricerca, attraverso l’osservazione e la sperimentazione, delle caratteristiche fondamentali dei fenomeni naturali; dall’altro la loro classificazione e interpretazione. Quest’ultima attività, che rappresenta l’aspetto più creativo del lavoro dello scienziato, si realizza attraverso la formulazione di particolari strumenti concettuali detti «teorie» e «modelli».
Una teoria scientifica non è, come comunemente si pensa, semplicemente una supposizione, ma un sistema di pensiero ben fondato, un insieme di proposizioni in grado di spiegare, in modo plausibile e coerente, le osservazioni di determinati fenomeni (naturali o conseguenti ad esperimenti di laboratorio), di giustificare le regolarità da esse derivate e di organizzare queste ultime all’interno di una struttura logica e unificante.
Si intende invece per modello scientifico (uno strumento di analisi molto diffuso nel campo delle scienze naturali) la visualizzazione semplificata e incompleta di una realtà invisibile, e quindi sconosciuta, mediate una o più immagini tratte dall’esperienza quotidiana. Un tipico esempio di modello scientifico è la struttura planetaria dell’atomo o la scala a chiocciola con la quale si usa rappresentare il DNA.
Un buon modello (e una buona teoria) deve rispondere a due richieste fondamentali: 1. – deve descrivere con precisione le osservazioni attraverso le quali il modello stesso è stato costruito; 2. – deve fare predizioni, ben definite, sui risultati di future osservazioni.
Un modello scientifico, pertanto, per quanto possa apparire coerente e profondo, non rappresenta affatto la realtà oggettiva, proprio come un modellino della Ferrari non rappresenta la «Rossa di Maranello», piena di congegni elettronici e di complicati dispositivi che le consentono di raggiungere e superare i 300 km/h sulle piste del Gran Premio. Esso, tuttavia, non è nemmeno qualcosa di arbitrario, frutto esclusivo dell’immaginazione dello scienziato, ma un’idea che trae origine dall’osservazione attenta e accurata della realtà materiale, alla quale peraltro rimane profondamente legato. Inoltre un modello, come d’altra parte una teoria, non è eterno poiché, per sua stessa natura, deve essere falsificabile: il che significa che deve essere sempre possibile immaginare un’osservazione o un esperimento che siano in grado di confutarlo. Qualora un’osservazione o un esperimento, eseguito materialmente, si dimostrassero effettivamente in disaccordo con le predizioni del modello, questo decadrebbe e verrebbe modificato o, in casi estremi, sostituito integralmente con un altro.
Per quanto riguarda quest’ultimo aspetto, si dice che un modello scientifico (o una teoria) possiede un elevato «contenuto euristico» quando è in grado di prevedere un gran numero di fatti la cui veridicità sarà dimostrata in un tempo successivo, e cioè, o quando si verificherà concretamente l’evento previsto, oppure quando l’uomo sarà entrato in possesso degli strumenti tecnici adeguati per il controllo del dato teorico.
Anche i modelli cosmologici che si susseguirono nel tempo ovviamente non avevano la pretesa di rappresentare l’Universo come è in realtà. Essi erano semplicemente delle costruzioni concettuali che servivano per descrivere in modo sintetico ciò che l’uomo, con lavoro meticoloso ed ordinato, era riuscito a conoscere, fino a quel momento, del mondo che lo circonda.
LE PRIME OSSERVAZIONI DEL CIELO
Ogni epoca e ogni civiltà ha avuto il suo modello di Universo, tuttavia l’uomo delle caverne quell’uomo che aveva dipinto e scolpito sulle pareti delle sue abitazioni tutto ciò che rappresentava l’esperienza quotidiana, dal bisonte ferito al cacciatore che scagliava la lancia contro la preda, non rappresentò mai un solo fenomeno celeste, nemmeno ad esempio il Sole, la Luna o un gruppo di stelle. Evidentemente l’uomo cacciatore e raccoglitore non aveva bisogno della conoscenza dei fenomeni celesti per condurre la propria esistenza.
Le tribù primitive conoscevano una porzione molto limitata del pianeta, quella in cui abitavano ed entro la quale si spostavano per procacciarsi il cibo. Quella regione, coperta dal Cielo che di notte appariva stellato, rappresentava, per loro, l’intero Universo. Le stesse stelle non dovevano essere molto lontane e comunque ad una distanza tale che la voce potesse raggiungerle e venivano identificate con divinità che si prendevano cura del genere umano il quale sarebbe stato punito se si fosse comportato male e premiato se si fosse comportato bene. Il tuono, il lampo, le comete, erano tutti elementi di un linguaggio celeste, spesso premonitore, di cui l’uomo primitivo non poteva non tenere conto.
La maggior parte dei fatti che si verificavano sulla Terra apparivano casuali e imprevedibili, mentre in Cielo gli astri seguivano percorsi sempre uguali a sé stessi e ciò dava garanzia di stabilità e di ordine. Anche sulla Terra, in verità, alcuni fenomeni importanti per la sopravvivenza del genere umano come la semina, il raccolto o la nascita del bestiame avvenivano sempre negli stessi periodi dell’anno, quindi vi doveva essere un rapporto stretto fra la posizione assunta dagli astri in Cielo e la vita degli uomini. Solo la convinzione che esseri umani e astri si potessero influenzare a vicenda giustificherebbe, infatti, il ricorso a pratiche e cerimonie magiche per invocare la pioggia e placare l’ira degli dei che, quando si spazientivano, facevano tremare la Terra e lanciavano pietre infuocate dai monti. Questi riti misteriosi e magici ebbero grande sviluppo fin dagli albori della civiltà antica, ma in alcuni casi si protrassero fino a tempi più recenti.
Quando l’uomo diventò sedentario e cominciò a coltivare la terra, sorse in lui la necessità di individuare un sistema in grado di predire i tempi migliori per la semina e per il raccolto. Questa esigenza è presente, molti secoli prima di Cristo, in tutte le civiltà, da quella cinese all’indiana, da quella delle genti che abitarono il Medio Oriente a quella delle popolazioni che vissero nel bacino del Mediterraneo, fino ai Maia che risiedevano in America. Verso la fine del V millennio a.C. gli Egizi erano in possesso di un calendario pratico fondato sulle osservazioni delle apparizioni eliache (cioè precedenti al sorgere del Sole) di Sirio. Questa stella, dopo essere stata per parecchio tempo invisibile, all’inizio dell’estate riappariva nel Cielo ad oriente poco prima dell’alba e lo faceva proprio nel momento in cui il Nilo inondava le terre rendendole fertili.
Presso i primi popoli civili ad un’osservazione superficiale del Cielo si mescolavano idee fantastiche suggerite dalla mitologia e dalle religioni con le quali si tentavano le prime spiegazioni dei fenomeni naturali e la costruzione delle prime rozze immagini dell’Universo. I Sumeri, ad esempio, e dopo di loro i Babilonesi, buoni conoscitori della matematica, usarono metodi empirici per determinare la posizione degli astri e i loro movimenti. Furono registrate molte osservazioni del moto della Luna e, in particolare, le posizioni del sorgere e del tramontare di essa e dei due pianeti più interni, Venere e Mercurio. In quel periodo i Cieli vennero divisi in zone e furono denominate le costellazioni. Il fine di tutte queste osservazioni era quello di fornire previsioni molto precise specialmente per quello che riguardava le eclissi e il ritorno periodico dei pianeti in determinate zone del Cielo, cosa questa molto importante per l’astrologia la quale, per essere credibile, aveva bisogno di sapere in anticipo in quale posizione si sarebbero trovati gli astri in un prossimo futuro. Le registrazioni dei fenomeni celesti erano quindi mirate soprattutto a soddisfare le esigenze astrologiche nella convinzione che nei Cieli si potessero trovare segni e presagi indicanti la prosperità futura dello Stato, mentre la convinzione che il destino del singolo individuo fosse scritto nelle stelle verrà solo in un secondo momento. Abili nell’uso degli strumenti e ricchi di conoscenze tecniche, ma poco desiderosi di comprendere i fenomeni del mondo naturale, gli antichi Babilonesi influenzarono i loro successori tecnicamente, ma non concettualmente.
Le origini del pensiero greco non sono diverse da quelle di tutti gli altri popoli. Nei Greci primitivi era ancora prevalente l’interpretazione mitica e magica dei grandi fenomeni della natura. Nel loro sistema cosmologico la Terra era considerata un disco piatto circondato dal fiume Oceano che si richiudeva formando la volta del Cielo. Terra e Cielo venivano così a formare un unico corpo a cui si attribuivano dimensioni molto limitate sia in senso orizzontale che verticale. Le idee sulla natura degli astri non potevano che ispirarsi a fenomeni terrestri o a fantasie mitologiche. Il carro del Sole, ad esempio, era guidato da Febo ed andava a spegnersi tutte le sere nell’Oceano; quando suo figlio Fetonte ottenne il permesso di guidare quel carro si lasciò prendere la mano dai focosi destrieri e deviò dal percorso producendo in Cielo un’indelebile scia, rappresentata dalla Via Lattea.
I PRIMI MODELLI DI UNIVERSO
L’inizio della civiltà greca non fu quindi molto promettente, ma ben presto le fantasie mitologiche lasciarono il posto alla razionalità e alla scienza. L’osservazione attenta del moto degli astri, con il loro tramontare e riapparire dall’altra parte del Cielo, dovette convincere i primi filosofi di quel Paese della necessità di separare la Terra dalla volta del Cielo e lasciarla isolata nello spazio. Talete, che all’inizio del VI secolo a.C. sembra sia stato in grado di prevedere un’eclissi di Sole attraverso lo studio dei calendari babilonesi e caldei, pensava che la Terra fosse un disco galleggiante sull’acqua come un pezzo di legno. Più tardi, Anassimandro elaborò una teoria sull’origine dei corpi celesti importante se non altro perché dimostrava che non si trattava di carri utilizzati dagli dei per i loro spostamenti, ma di oggetti suscettibili di misurazione.
Alla scuola di Talete e Anassimandro si oppose quella dei pitagorici, meno materialista e invece più interessata alle caratteristiche essenziali del cosmo. Pitagora stesso vedeva nel numero il principio di ogni cosa e quindi per lui l’Universo rappresentava l’unità. In un tempo successivo i pitagorici ritennero che i movimenti del Sole e del Cielo notturno fossero moti apparenti e che in realtà fosse la Terra a muoversi lungo una circonferenza. Verso la fine del V secolo a.C. Filolao arricchì il modello di Universo ponendovi nel mezzo un grande «fuoco centrale» che non poteva essere visto perché situato dalla parte opposta della Terra, la quale si muoveva mostrando ad esso sempre la stessa faccia (come fa oggi la Luna nei confronti della Terra). Secondo Filolao l’Universo era costituito di dieci corpi che ruotano intorno al fuoco centrale: la Terra, la Luna, il Sole, i 5 pianeti, le stelle fisse e l’anti-Terra, quest’ultima necessaria per spiegare le eclissi, ma soprattutto per rispettare un presupposto ordine rappresentato dal numero 10, simbolo della perfezione perché in esso è racchiuso uguale numero di pari e dispari, vi si trova l’unità con il primo pari, vi è il primo dispari con il primo quadrato (il 4) e infine risulta dalla somma del 3 col 7, due numeri magici simbolo di saggezza. Anche l’anti-Terra non poteva essere vista perché sistemata fra la Terra e il fuoco centrale, mentre gli altri corpi ruotavano con velocità decrescente verso l’esterno in modo da riprodurre i fenomeni osservati. Il modello di Universo dei pitagorici è importantissimo perché rappresenta il primo tentativo di mostrare una interpretazione cosmologica sulla base di una filosofia precostituita, ma anche di alcune osservazioni fondamentali.
Nel frattempo fioriscono dei tentativi per giungere ad una vera e propria scienza della natura e nascono quindi alcune cosmologie svincolate dai miti religiosi e basate esclusivamente sulla natura materiale dei corpi celesti. Fra queste vi era quella di Empedocle secondo il quale l’Universo è sferico e riempito di materia formata da un insieme di corpuscoli di quattro specie diverse che lui chiama «radici delle cose», e che in seguito diventeranno i quattro elementi: terra, acqua, aria e fuoco. Per Democrito, viceversa, il fondamento materiale del cosmo è costituito da un numero infinito di atomi invece che da un numero finito di elementi. Tutti gli atomi sono dotati di movimento casuale ed eterno e quando si uniscono lo fanno rispettando la regola che vuole che il simile cerchi il simile. La teoria atomistica sfociava inevitabilmente nel concetto dell’infinità dell’Universo con conseguente numero infinito di mondi, sparsi in uno spazio senza limiti, abitati come la Terra e soggetti ad evolversi e a modificarsi. Per Democrito nella natura non vi è forza ordinatrice, principio o divinità; nulla è spirituale e anche lo spazio ha proprietà matematiche: esso non è altro che il vuoto privo di qualità e assolutamente omogeneo.
Le continue dissertazioni di ordine filosofico che si inserivano nella questione della natura del cosmo ebbero l’effetto di rendere le osservazioni sempre più accurate e dettagliate. Le apparenze, come si sa, ingannano e quindi solo le misurazioni possono chiarire se ciò che si osserva è reale o no. Ad esempio, la Luna e il Sole appaiono rotondi: sono effettivamente tali? Durante le eclissi di Luna il contorno dell’ombra (che dovrebbe essere quella della Terra proiettata dal Sole) è sempre rotondo: ciò è conseguenza del fatto che la Terra è sferica? E le fasi lunari sono l’effetto di una particolare reciproca posizione di Sole, Terra e Luna? Fra il V e il IV secolo a.C. partendo da modelli capaci di inquadrare i dati dell’osservazione, e utilizzando i risultati già noti della geometria, si riuscì a realizzare le prime misure cosmiche.
LE PRIME MISURE DEL CIELO
Quando la Luna si trova nella fase di primo o ultimo quarto e quindi appare illuminata dal Sole esattamente metà della sua faccia rivolta alla Terra, fra Terra, Sole e Luna si forma un triangolo rettangolo con l’angolo retto sulla Luna. Ora, misurando da Terra l’angolo compreso fra la visuale alla Luna e quella al Sole, risulta determinato anche il terzo angolo del triangolo e di conseguenza il rapporto fra le lunghezze dei lati. La misura dell’angolo risultò molto imprecisa, ma il sistema in sé era valido e consentì ad Aristarco di Samo, 300 anni prima di Cristo, di concludere che il Sole era circa 20 volte più lontano della Luna. In realtà il Sole è 400 volte più lontano della Luna ma il risultato, anche se molto approssimativo, fu tuttavia sufficiente per dedurre che poiché i due astri appaiono in Cielo di grandezza quasi uguale, il Sole, per il fatto di essere più lontano, doveva essere molto più grande della Luna e, presumibilmente, anche della Terra. Ora, poiché si osserva che sono i corpi più piccoli a girare intorno ai più grandi e non viceversa, Aristarco arrivò alla conclusione che avrebbe dovuto essere la Terra a girare intorno al Sole e non il Sole intorno alla Terra come appariva ad un’osservazione affrettata. Naturalmente per avere un’idea più precisa delle effettive dimensioni dei due astri era necessario conoscere la distanza Terra-Luna.
Nella misurazione di questa distanza si cimentò Ipparco di Nicea utilizzando un metodo assai ingegnoso suggerito dallo stesso Aristarco. Si trattava di misurare il tempo che la Luna impiegava ad attraversare, durante una sua eclisse totale, il cono d’ombra della Terra. Da questa osservazione Ipparco dedusse che la Luna è circa tre volte più piccola della Terra. Ora, poiché la Luna appare in Cielo delle dimensioni di mezzo grado, con 720 Lune (il doppio dei gradi dell’angolo giro) poste una a fianco all’altra, si sarebbe potuta costruire una enorme circonferenza intorno alla Terra. La lunghezza di questa circonferenza sarebbe stata di 720 diametri lunari, pari a 240 diametri terrestri (720:3=240). Questo valore, diviso per 2π rappresentava il raggio della circonferenza, ossia la distanza fra la Terra e la Luna e corrispondeva a circa 38 diametri terrestri, una misura molto vicina al vero. Con tale dato, unito alle misurazioni precedenti, fu possibile stabilire che il diametro del Sole era sei o sette volte superiore al diametro terrestre. In realtà il diametro del Sole è 100 volte maggiore di quello della Terra.
Rimanevano da determinare le dimensioni della Terra. A ciò provvide il responsabile della biblioteca di Alessandria, Eratostene di Cirene, duecento anni prima di Cristo, quando lesse su un papiro (il libro di quei tempi) che a Siene, una città posta quasi esattamente a sud di Alessandria, nel giorno del solstizio d’estate, a mezzogiorno, il Sole si trovava allo zenit, mentre ad Alessandria, nello stesso giorno e alla stessa ora, il Sole si discostava di 7° e 12′ dalla verticale. Sapendo che il Sole è molto lontano e che quindi i suoi raggi, quando giungono a terra, possono essere considerati paralleli, non è difficile desumere che l’angolo di 7° e 12’ corrisponde all’angolo, misurato al centro della Terra, compreso fra le città di Siene e Alessandria. Ora, poiché quest’angolo rappresenta un cinquantesimo dell’angolo giro (360°:7,2°=50), un cinquantesimo di tutta la circonferenza doveva essere anche la distanza fra Siene ed Alessandria che a quel tempo era valutata in 5.000 stadi. Pertanto, moltiplicando 5.000 per 50 si sarebbe ottenuto la circonferenza della Terra che risultò infatti di 250.000 stadi pari a circa 40.000 km, un valore sorprendentemente molto vicino al vero.
Nonostante i successi nelle misurazioni di alcune distanze cosmiche, le stelle rimanevano infisse sulla superficie interna di una sfera le cui dimensioni, ancorché ignote, erano tuttavia ritenute molto grandi specie da coloro i quali pensavano che la Terra percorresse un’orbita intorno al Sole. Quest’orbita infatti avrebbe dovuto essere di dimensioni trascurabili rispetto al raggio della volta celeste perché se fosse stata grande, la Terra si sarebbe spostata in modo considerevole nel corso dell’anno e la posizione reciproca delle stelle, viste da punti molto lontani fra loro, avrebbe dovuto cambiare notevolmente, mentre rimaneva immutata. La conclusione logica era che la volta celeste doveva essere molto lontana e il moto notturno degli astri non poteva dipendere dalla rotazione della sfera sulla quale gli stessi stavano infissi, a causa della enorme velocità periferica che ne sarebbe derivata. Pertanto quel moto doveva essere apparente e conseguente all’effettiva rotazione della Terra intorno al suo asse.
Il modello eliocentrico di Universo si basava su misure inquadrate all’interno di leggi fisiche e non poteva essere accettato da chi vedeva le cose reali soggette a leggi di altra natura, come ad esempio a quelle basate sull’armonia e sull’ordine, e fu infatti trascurato. Fu invece curato, perfezionato e adattato ai fenomeni osservati e alle misure eseguite il modello geocentrico, tanto è vero che questo si impose sull’altro.
Fra i più noti sostenitori dei moti celesti secondo modelli che ponevano la Terra immobile al centro dell’Universo e tutto il resto a girarle intorno, si ricordano Eudosso e Aristotele. Il primo riprodusse i moti apparenti degli astri ricorrendo ad un sistema di 27 sfere concentriche e il secondo addirittura di 55. Il modello di Aristotele si rifaceva alle idee di Platone che distingueva il mondo perfetto e immutabile delle idee da quello imperfetto e corrotto degli oggetti materiali. Da questa visione filosofica delle cose derivava una distinzione di carattere qualitativo fra i corpi celesti perfetti dove il moto circolare rappresentava l’ordine eterno, e la Terra mutevole e imperfetta dove invece prevalevano i moti rettilinei.
Così per Aristotele la perfezione dei moti celesti era insita nella natura stessa dei corpi coinvolti in quei moti. Essi dovevano essere formati di una sostanza speciale, una quinta essenza, detta etereda un termine greco che significa “brillare”. Il mondo sublunare, cioè la Terra e l’atmosfera che l’avvolge, dove gli oggetti cadono o salgono invece che girare attorno, era costituito dai quattro elementi fondamentali di Empedocle, cioè terra, acqua, aria e fuoco i quali, se venivano spostati dalla loro posizione naturale, tendevano poi spontaneamente a ritornarvi muovendosi verso il basso (terra e acqua) o verso l’alto (aria e fuoco). Interessante anche, nel pensiero di Aristotele, la superiorità del moto circolare rispetto a quello rettilineo che per ritornare al punto di partenza obbliga a fare ricorso a un moto contrario, mentre sulla circonferenza per tornare indietro si procede sempre nello stesso senso.
IL MODELLO TOLEMAICO DI UNIVERSO
Agli inizi del IV secolo a.C. si conoscevano abbastanza bene i movimenti dei pianeti che in alcuni casi non apparivano affatto ordinati. Ciò valeva soprattutto per i pianeti esterni (Marte, Giove e Saturno), quelli che viaggiano più lentamente rispetto alla Terra la quale li raggiunge e li sorpassa ad intervalli di tempo regolari. Visto da Terra, un pianeta, in alcuni giorni dell’anno, sembrava rallentare il suo moto, fermarsi e tornare indietro (moto retrogrado), quindi fermarsi di nuovo per riprendere il moto diretto. Platone era convinto che queste anomalie potessero essere spiegate senza rinunciare al moto perfettamente circolare che rappresentava, secondo lui, il movimento naturale dei Cieli.
La prima soluzione per giustificare questi movimenti anomali fu individuata da Eudosso attraverso l’introduzione delle 27 sfere concentriche alle quali abbiamo già accennato. Egli immaginò di porre ogni pianeta sull’equatore di una sfera ruotante con velocità uniforme, ma messa a sua volta in movimento da una seconda sfera più ampia, ruotante anch’essa sul proprio asse con velocità uniforme, anche se diversa dalla prima. Poi eventualmente vi erano una terza e una quarta sfera collegate sempre attraverso i loro assi di rotazione che girando con velocità differenti imprimevano al pianeta il suo moto caratteristico. Le sfere, come abbiamo detto, erano in tutto 27 (tre per il Sole, tre per la Luna, quattro per ciascuno degli altri pianeti e una per le stelle fisse) e avevano tutte lo stesso centro che cadeva al centro della Terra (anch’essa di forma sferica), ma i poli di ognuna di esse erano differenti e di conseguenza differenti erano anche le loro rotazioni.
Sennonché le sfere di Eudosso non erano sfere materiali, ma matematiche, quindi teoriche come teorico era il modello da lui creato. Ciò turbò Aristotele il quale avrebbe preferito un modello fisico con sfere reali costituite, come abbiamo detto, di un materiale adeguato alle regioni celesti e pertanto perfetto, indistruttibile e trasparente come il cristallo. Per raggiungere il suo obiettivo, Aristotele aggiunse al sistema di sfere di ogni pianeta una sfera “reagente” al suo interno e una sfera “deferente” al suo esterno, in movimento con la stessa velocità, ma in senso opposto, in modo da assicurare l’indipendenza dei vari moti celesti. Il sistema “meccanico” di Aristotele, con il suo elevato numero di sfere (55) interconnesse fra loro in modo da garantire l’unità del Cosmo era collegato ad un motore, quello che Aristotele stesso chiamò il «primo mobile». Il modello, incredibile a dirsi, giustificava perfettamente i moti dei pianeti noti a quel tempo.
Frattanto però le osservazioni si andavano facendo sempre più attente e raffinate e per giustificare i dati dell’osservazione era necessaria l’introduzione di ulteriori aggiustamenti al sistema meccanico di Universo. Si provvide quindi ad aggiungere i cosiddetti «epicicli», cioè circonferenze su cui venivano fatti girare i pianeti. Gli epicicli, a loro volta, si muovevano lungo il «deferente», un altro cerchio il cui centro era sistemato al centro della Terra. Adattando sia la velocità che le grandezze dei cerchi ad ogni singolo caso, fu possibile ottenere una rappresentazione matematica assai soddisfacente del movimento dei pianeti.
All’incirca 150 anni dopo Cristo, il modello di Universo fino ad allora elaborato venne sistemato e completato da quello che è considerato l’ultimo dei grandi astronomi matematici greci, Claudio Tolomeo. La sua opera, in tredici volumi, si intitola Mathematike Synthasis (“Compilazione matematica”), ma è generalmente conosciuta con il nome di «Almagesto», perché nella tarda antichità divenne nota come Magiste Synthasis (“Grande compilazione”). I traduttori arabi trasformarono il titolo in Al-Magjisti, che vuol dire “Il più grande”, da cui il successivo latino Almagestum. In essa l’astronomo alessandrino forniva una rappresentazione del Cosmo che potremmo così sintetizzare: 1) l’Universo è finito ed eterno, limitato dalla sfera delle stelle fisse che ruota intorno al proprio asse da oriente ad occidente; 2) al centro è la Terra, sferica anch’essa, che volge verso l’alto la parte abitata; 3) i pianeti girano su sfere di cristallo intorno al centro dell’Universo percorrendo gli epicicli a distanze tanto maggiori quanto più lento è il loro movimento.
Ora però, anche così congegnato, il modello non riusciva a giustificare i dati osservativi che nel frattempo erano diventati numerosi e sufficientemente precisi. Ci si era accorti, ad esempio, di una variazione di luminosità di alcuni pianeti che non poteva che dipendere da una variazione della distanza nel loro movimento intorno alla Terra. Tolomeo si trovò quindi nella necessità di complicare il precedente schema generale in maniera determinante. La prima modifica fu quella di spostare leggermente la Terra dalla sua posizione e quindi individuare un punto, vicino al centro dell’Universo, ma sistemato dalla parte opposta della Terra, detto «punto equante» rispetto al quale i centri degli epicicli sul deferente si muovevano di moto angolare uniforme. Ora però siccome il punto equante non corrispondeva al centro dell’Universo, ciò equivaleva a dire che i pianeti non si muovevano con moto uniforme.
Il modello di Universo costruito da Tolomeo era obiettivamente complicato, tuttavia i dati di osservazione relativi ai vari pianeti venivano rappresentati assai bene al punto da poter affermare che il mondo doveva essere fatto proprio come il modello faceva vedere. E’ da notare che il modello di Universo costruito dai greci era molto simile a quelli costruiti da altre civiltà sparse in tutto il mondo a dimostrazione del fatto che con le osservazioni effettuabili a quel tempo non era possibile inventare qualche cosa di sostanzialmente diverso da ciò che seppe esprimere la cultura greca.
Il modello dei greci ovviamente si accordava bene anche con quanto veniva riportato dalle Sacre Scritture e venne infatti adottato dalla Chiesa di Roma. Esso venne scelto anche perché aveva la prerogativa di lasciare, oltre la sfera delle stelle fisse, tutto lo spazio che si voleva per sistemare Inferno e Paradiso.
La cosa sorprendente è che il modello geocentrico, nonostante fosse un modello sbagliato (la Terra gira intorno al Sole e non viceversa), funzionava perfettamente. Oggi conosciamo il motivo di questa apparente contraddizione: sappiamo infatti che non esiste un sistema assoluto di riferimento, ma che tutti i moti sono relativi.
Per «sistema di riferimento» si intende l’insieme dei corpi che, nello studio di un moto, vengono considerati fermi. A seconda di come viene definito il sistema di riferimento si ottengono valori diversi degli spostamenti degli oggetti in movimento: così, quando ad esempio vogliamo prendere in esame il movimento di un’automobile, consideriamo ferma la Terra, e quando vogliamo definire il percorso seguito da un bambino che corre avanti e indietro per i corridoi del treno in viaggio, consideriamo fermo il treno. Ma nello studio di un moto, è indifferente adottare l’uno o l’altro dei sistemi di riferimento possibili. Nel caso del bambino sul treno ad esempio si potrebbe considerare ferma la Terra e non il treno: i movimenti del bambino troverebbero lo stesso una descrizione precisa, anche se più complicata.
Allo stesso modo, per descrivere il moto dei pianeti, si preferisce, con ovvia semplificazione, considerare fermo il Sole, ma si potrebbe considerare ferma la Terra: i moti risulterebbero in questo caso più contorti, ma non per questo errati. Il sistema eliocentrico non deve quindi essere ritenuto più “vero” di quello geocentrico, ma semplicemente più “comodo”.
Ora però, a mano a mano che si raffinavano le osservazioni relative al moto dei corpi celesti, si scoprivano fenomeni che, per essere inquadrati nel modello geocentrico, rendevano quest’ultimo sempre più complicato e la complessità, in campo scientifico, è un brutto segno. Una delle prerogative dei modelli scientifici deve essere infatti la semplicità perché la semplicità rende più agevole la comprensione del fenomeno che il modello stesso deve descrivere.
IL MODELLO COPERNICANO DI UNIVERSO
Nel 1543 uscì alle stampe un libro dal titolo «De revolutionibus orbium coelestium» dell’ecclesiastico polacco Niccolò Copernico, in cui veniva descritto il modello eliocentrico di Universo; in virtù di esso alcuni calcoli, necessari a prevedere la posizione dei pianeti in Cielo, risultavano più agevoli rispetto a quelli che era necessario eseguire con il modello geocentrico.
L’opera di Copernico venne quindi presentata in un primo momento come semplice modello matematico, cioè come strumento utile per descrivere il moto dei corpi celesti. Esso però, in seguito, si rivelò una costruzione ricca di razionalità e tale da sovvertire dalle fondamenta l’intera concezione cosmologica, come si era andata consolidando nei secoli.
Non è chiaro quali fossero le reali intenzioni di Copernico, cattolico integralista e aristotelico convinto, ma il fatto che il suo scritto venisse pubblicato solo dopo la sua morte, pone qualche dubbio sul vero significato che l’autore intendesse dare al suo lavoro. La stessa Chiesa Cattolica non riuscì a percepire immediatamente il pericolo insito nell’opera di Copernico, mentre ad esempio le Chiese Protestanti di Lutero e di Calvino, condannandola immediatamente e senza mezzi termini, si dimostrarono da questo punto di vista più lungimiranti.
La struttura eliocentrica del mondo, contrabbandata come innocuo modello matematico, poté quindi circolare liberamente in Europa fino alla fine del sedicesimo secolo. Il modello però, come abbiamo detto, rivelò ben presto tutto il suo reale potenziale euristico e permise di sviluppare i concetti che racchiudeva in sé confrontandoli meticolosamente con le osservazioni. Il lavoro di ricerca e di interpretazione svolto da Giordano Bruno e soprattutto da Galileo Galilei, travalicò il pensiero stesso di Copernico, e finì per sconvolgere i principi della tradizione e della fede, scatenando la reazione della Chiesa di Roma. Con la Terra sistemata in posizione periferica e non al centro dell’Universo dove era sempre stata, non era più ben chiaro, ad esempio, dove dovessero sistemarsi Inferno e Paradiso. L’opera di Copernico venne allora messa all’indice (donec corrigatur = fino a quando non sarà corretta) e vi rimase fino al 1820!
Isaac Newton, lo scopritore della legge di gravitazione universale, avrebbe potuto diventare il fondatore della cosmologia moderna se non avesse commesso un grave errore di meccanica nel tentativo di salvare l’immobilismo cosmico. Egli, come tutti i suoi contemporanei, pensava che le stelle fossero fisse e immutabili e poiché egli stesso aveva scoperto che i corpi materiali, liberi di muoversi, si attraggono reciprocamente e tendono a collassare verso una massa centrale, per non contraddire il principio della staticità del Cosmo, sostenne che l’Universo doveva essere infinito e popolato uniformemente di stelle così che la forza risultante, e quindi il movimento complessivo, fosse nullo. Ma se una stella rimane in equilibrio perché attratta in uguale misura da un numero infinito di altre stelle la stessa cosa dovrebbe valere per la Terra la quale dovrebbe stare ferma perché anch’essa attratta in tutte le direzioni da un numero infinito di stelle.
In verità il modello di Universo di Newton si rivelò, nei fatti, pieno di contraddizioni. Fra l’altro, se lo spazio fosse realmente infinito e uniformemente popolato da un numero infinito di stelle, ogni singola stella sarebbe attratta da una parte con una forza infinita e dalla parte opposta con la stessa forza infinita: infinito meno infinito tuttavia non fa zero, ma indeterminato. La soluzione del problema sta nel riconoscimento che le stelle non sono fisse: esse si attraggono ma contemporaneamente si muovono descrivendo traiettorie ellittiche proprio come fanno i pianeti e le comete. Si dovrà aspettare ancora molto tempo prima di mettere in moto quello che ancora oggi chiamiamo «firmamento», cioè il luogo degli oggetti fermi.
Sarà necessaria la teoria della relatività generale di Einstein per entrare in possesso del quadro concettuale indispensabile per la formulazione del primo modello di Universo di sicuro valore scientifico; prima di descriverlo tuttavia è necessario soffermarsi sulle osservazioni che consentirono la sua costruzione.
LE OSSERVAZIONI DEL XIX SECOLO
Nonostante i ripetuti tentativi fatti in passato, solo nel 1838 l’astronomo tedesco Friedrich Bessel fu in grado di determinare, con il sistema della parallasse, la prima distanza precisa di una stella. Con quella misura, che rappresentò fra l’altro la prova certa del moto della Terra intorno al Sole, ebbe inizio l’astronomia moderna come scienza esatta e si aprì la strada alle successive scoperte. Alcuni anni prima John Herschel (1738–1822) aveva osservato che le stelle hanno un proprio movimento peculiare che appare tanto più evidente quanto più sono vicine; in tal modo egli suggeriva a Bessel quale fosse la stella più adatta per la determinazione della sua distanza.
Dal nostro punto di vista la scoperta più interessante si ebbe nel 1859 con il fisico Gustav Kirchhoff e con il chimico Robert Bunsen i quali riuscirono ad interpretare le righe degli spettri di assorbimento delle stelle. Vediamo di che cosa si tratta.
Già Newton aveva sperimentato che la luce bianca di un corpo incandescente, se viene fatta passare attraverso un prisma di materiale trasparente, si scinde in vari colori (i colori dell’arcobaleno), dando luogo a quello che comunemente viene chiamato uno «spettro». Successivamente, nel 1815, lo scienziato tedesco Joseph von Fraunhofer aveva osservato che lo spettro solare, ottenuto facendo passare la luce attraverso una stretta fessura posta davanti al prisma trasparente, risultava solcato da una miriade di righe scure (egli stesso ne aveva contate più di 500) delle quali però non seppe dare una giustificazione. Finalmente Kirchhoff e Bunsen, in seguito ad un meticoloso lavoro sperimentale, scoprirono che gli elementi chimici, portati ad incandescenza, emettono luce che, costretta a passare per una fenditura prima di attraversare il prisma trasparente, genera una serie di righe caratteristiche di vari colori, diversa da elemento ad elemento. I due scienziati tedeschi osservarono, in altre parole, che ogni elemento chimico possiede una specie di personale «impronta digitale» molto tipica. A quel punto, analizzando la luce delle stelle, fu possibile determinare la presenza in esse di svariati elementi e quindi, in pratica, di determinare la loro composizione chimica.
La scoperta, a quel tempo, destò enorme sensazione anche perché solo qualche anno prima il filosofo francese Auguste Comte, padre del positivismo, predisse che l’uomo non sarebbe mai stato in grado di scoprire di che cosa sono fatte le stelle. L’affermazione di Comte invita alla prudenza coloro i quali asseriscono che l’uomo non potrà mai raggiungere determinati risultati in campo scientifico.
La scoperta che le stelle erano costituite degli stessi elementi chimici presenti sulla Terra, unita all’osservazione che quelle stesse stelle erano dotate di movimento proprio, portò al convincimento che esse dovessero nascere e morire e che quindi non potevano essere eterne. Tuttavia, queste osservazioni non furono ancora sufficienti ad indirizzare la mente dei fisici verso l’idea di un Universo in evoluzione.
E nemmeno la scoperta dei processi di trasmutazione nucleare fu determinante per convincere gli astronomi che il Cosmo doveva essere in continuo mutamento. Le trasmutazioni nucleari, scoperte all’inizio di questo secolo, producono annichilimento della materia la quale lentamente, ma inesorabilmente, si trasforma in energia quindi le stelle all’interno delle quali avvengono queste trasformazioni della materia, inevitabilmente si consumano e sono pertanto destinate a morire.
Se si considera che in biologia la teoria evoluzionistica si era affermata da oltre cento anni, il fatto che fino a poco tempo fa vi fosse ancora qualche eminente scienziato che riteneva che l’Universo dovesse essere fisso e immutabile, ha semplicemente dell’incredibile.
LA NUOVA TEORIADELLA GRAVITAZIONE
Si arriva così al 1917, anno in cui Albert Einstein (1879-1955) presentò il suo modello di Universo: esso traeva origine dalla teoria della relatività generale, la quale non aveva tuttavia come obiettivo la cosmologia. La teoria della relatività generale è infatti una teoria del campo gravitazionale, una teoria cioè che descrive la forza di gravità in modo nuovo e, per questo motivo, viene anche chiamata «Teoria di Einstein della gravitazione».
La forza di gravità, secondo Einstein, è la conseguenza della deformazione che subisce lo spazio a causa della presenza in esso della materia. La materia quindi deformerebbe lo spazio e lo renderebbe pieno di avvallamenti e gobbe. Che cosa significa? Significa, innanzitutto, che lo spazio a tre dimensioni che noi percepiamo direttamente con i nostri sensi in realtà dovrebbe avere una dimensione in più. Vediamo di spiegare perché.
Pensiamo ad un foglio di carta disteso: esso rappresenta uno spazio a due dimensioni; ebbene, se noi volessimo ripiegare questo foglio avremmo bisogno di una terza dimensione entro cui poterlo fare. Allo stesso modo lo spazio a tre dimensioni che ci sta davanti agli occhi, per potersi ripiegare e modellare ad avvallamenti e gobbe ha bisogno di una quarta dimensione entro cui poterlo fare. A questo punto forse è opportuno chiarire meglio cosa si intende per spazio a quattro dimensioni.
Anche se non è possibile visualizzare uno spazio a quattro dimensioni (già a tre è difficile), è possibile tuttavia farsi un’idea di esso ricorrendo ad un’analogia. Immaginiamo allora di avere a che fare con un individuo bidimensionale (cioè piatto), che vive su una superficie piatta. E’ chiaro che questo individuo potrà spostarsi sulla superficie in tutte le direzioni, ma non potrà mai alzarsi al di sopra o scendere al di sotto di essa né percepire o misurare alcunché fuori dalla superficie su cui è costretto a strisciare. Il piano è l’unica estensione che si presenta con immediatezza ai suoi sensi. Per lui, ad esempio, dire “sopra o sotto la superficie” non avrebbe alcun significato, proprio come per noi, esseri tridimensionali, non ha senso dire “sopra o sotto lo spazio”.
Ora, l’individuo bidimensionale che vive su una superficie piana di dimensioni infinite (o che ritiene tali), se fosse intelligente, con l’aiuto della sola logica, si potrebbe rendere conto della possibilità di esistenza di altri tipi di superfici, per esempio incurvate in una terza dimensione come la superficie di una sfera o quella di una sella. Non solo, all’individuo bidimensionale intelligente non dovrebbe nemmeno essere impossibile dimostrare, con misure di vario genere, quale tipo di superficie potrebbe eventualmente essere quella su cui vive.
Se disegnasse, ad esempio, sulla superficie su cui giace, dei triangoli di notevoli dimensioni, e ne misurasse, con la massima cura, gli angoli interni, potrebbe trovare una somma pari a 180° oppure diversa da 180°. Nel primo caso si convincerebbe di essere su una superficie piatta, sulla quale vale la geometria euclidea, mentre nell’altro caso capirebbe di non trovarsi su una superficie piana e precisamente avrebbe la prova di trovarsi su una superficie sferica, qualora misurasse valori superiori a 180° e su una superficie iperbolica (cioè a forma di sella), qualora misurasse valori inferiori a 180°. Sulla superficie della sfera, come sulla superficie di una sella, non vale la geometria euclidea e pertanto la somma degli angoli interni dei triangoli non è 180°.
Ebbene, quello che abbiamo detto per gli esseri bidimensionali, vale anche per noi tridimensionali. L’intuizione più immediata, quella che meglio risponde all’esperienza quotidiana, è che lo spazio in cui viviamo sia uno spazio tridimensionale che potremmo definire «piatto», cioè privo di curvatura, che si estende ovunque all’infinito. Tuttavia questa intuizione basata sul buon senso è errata e dimostra fra l’altro che non è attraverso il buon senso (e ancor meno attraverso il senso comune), che l’uomo è mai riuscito a capire come funziona il mondo. Per capire come stanno effettivamente le cose in natura è necessario elaborare delle astrazioni e procedere a delle misurazioni.
Come la superficie piana non è l’unica superficie a due dimensioni che esista, così lo spazio piatto non è l’unico spazio a tre dimensioni che si possa immaginare. I matematici, ad esempio, sono in grado di descrivere spazi a quante dimensioni si desidera (tre, quattro, dieci, cento) e spazi piani, curvi o contorti in vario modo, creando un vastissimo capitolo della geometria.
Tuttavia lo spazio fisico reale, quello cioè in cui viviamo, è uno solo e non è un’astrazione matematica. Quale degli spazi che si possono teoricamente immaginare è quello effettivo in cui operiamo? La risposta, come sempre nella scienza, non potrà che venire dall’osservazione e dalla sperimentazione. Vediamo innanzitutto in che modo Einstein riuscì ad intuire che lo spazio in cui viviamo non può essere uno spazio a tre sole dimensioni.
Fino ai tempi di Einstein la gravitazione era stata interpretata come un’azione a distanza di un corpo più pesante su uno più leggero. Per Newton infatti un corpo massiccio, per esempio il Sole, genera una forza, la forza di gravità appunto, la quale attrae i corpi più piccoli i quali però, girandogli attorno evitano di cadergli addosso. Secondo Einstein, invece, quello della forza di gravità è un concetto che deve essere rivisto: due corpi si attraggono perché rotolano in uno spazio pieno di avvallamenti e buchi. Si potrebbe anche immaginare un corpo massiccio che incurva, con la sua presenza, lo spazio intorno a sé, alterandone la geometria: nella depressione generata dal corpo di grosse dimensioni rotola quindi un corpo più piccolo che gli passa vicino, dando l’impressione di venire attirato da questo.
Ecco perché serve una quarta dimensione. Le tre dimensioni dello spazio ordinario, per potersi incurvare, hanno bisogno, evidentemente, di una dimensione aggiuntiva entro cui poterlo fare, così come una superficie piana a due dimensioni, ha bisogno, per potersi incurvare, di occupare una terza dimensione.
Torniamo ora alla nuova interpretazione della gravitazione fornita da Einstein. Qualora un oggetto di piccole dimensioni, che si muovesse di moto rettilineo ed uniforme, si trovasse a passare in vicinanza di un oggetto massiccio, a causa della depressione provocata da quest’ultimo, accelererebbe il moto e devierebbe dal suo cammino rettilineo, dando l’impressione di venire da questo attirato. L’esistenza di una forza attrattiva fra i corpi è quindi solo una sensazione, perché in realtà non si tratta di una forza in senso stretto, ma della manifestazione dello spazio-tempo deformato.
Lo spazio tetradimensionale si chiama spazio-tempo in quanto Einstein individuò proprio nel tempo la quarta dimensione dello spazio. Il tempo quindi non già in quanto tale e distinto dallo spazio, ma come dimensione spaziale vera e propria da considerare insieme con le altre tre in un’unica entità fisica.
Lo spazio-tempo non è, tutto sommato, un concetto di difficile comprensione: in esso ci imbattiamo anche nella vita di tutti i giorni. Quando ad esempio diamo appuntamento a qualcuno, specifichiamo non solo il luogo, ma anche il tempo, altrimenti non ci si riuscirebbe mai ad incontrare nello stesso luogo e nello stesso tempo.
Nella teoria della relatività generale, materia, spazio e tempo risultano quindi unificati in un’unica realtà. Einstein riuscì infine a dare rigore matematico alla sua intuizione fornendo una serie di equazioni del campo gravitazionale in grado di esprimere con esattezza l’entità della curvatura dello spazio-tempo, causata dalla presenza della materia.
La nuova teoria, tuttavia, per essere accettata, doveva essere in grado di fare anche delle previsioni, fornendo dei progetti di verifica. Il primo esperimento di controllo fu suggerito dallo stesso Einstein: quando la luce di una stella posta dietro al Sole ne sfiora il bordo, dovrebbe venire attratta da questo. In realtà la luce non viene attratta dal Sole: è lo spazio, intorno all’astro centrale, che risulta ripiegato e la luce non fa altro che seguire l’avvallamento dando la sensazione di deviare dalla linea retta. Einstein calcolò con precisione di quanto avrebbe dovuto essere questa deviazione. Il 29 maggio 1919 l’astronomo inglese Arthur Eddington, in occasione di un’eclissi totale di Sole, verificò puntualmente la previsione contenuta nella teoria della relatività generale: i fotoni, percorrendo lo spazio-tempo curvo intorno al Sole, deviano dalla loro traiettoria rettilinea esattamente del valore previsto da Einstein. Non è frequente trovare un inglese disposto ad avallare le idee di un tedesco!
IL MODELLO EINSTEINIANO DI UNIVERSO
A questo punto Einstein pensò di applicare la sua teoria all’Universo intero. Sennonché, la teoria della relatività generale è una teoria matematica, e non una teoria fisica, e fra i due tipi di teorie vi è una notevole differenza. Una teoria matematica infatti è sempre “giusta”, a meno che i calcoli non siano sbagliati, mentre una teoria fisica è giusta solo se descrive correttamente i fenomeni. Vediamo di rendere chiaro questo concetto con un esempio.
Si immagini di lanciare un sasso: quale traiettoria percorrerà nell’aria e dove andrà a cadere? La traiettoria del sasso potrebbe essere descritta da un matematico il quale, con carta e penna, potrebbe fornirci le equazioni che ne definiscono il moto, ma non sarebbe mai in grado di descrivere l’effettivo percorso seguito dal sasso e dirci dove andrà realmente a cadere se non gli forniamo qualche indicazione aggiuntiva, come ad esempio la direzione verso cui viene lanciato e la forza con cui viene lanciato. Sono queste condizioni esterne (dette con termine tecnico «condizioni al contorno») che permettono di applicare a casi concreti formule matematiche altrimenti generiche. In altri termini una teoria fisica non è altro che una teoria matematica, nella quale gli enti matematici astratti sono stati riempiti di contenuto facendo loro corrispondere opportune grandezze fisiche.
Ritorniamo ora alla teoria della relatività generale. E’ evidente che si tratta di una teoria matematica destinata quindi a produrre una varietà praticamente infinita di Universi, se non vengono fissate precise condizioni fisiche iniziali. Tuttavia, la scelta dei parametri fondamentali da cui partire è un’operazione tutt’altro che banale.
Innanzitutto è indispensabile che i parametri iniziali non siano né troppi, né troppo pochi, perché solo in questo modo le equazioni potranno fornire soluzioni chiare e precise. Se le condizioni iniziali fossero troppe, come nel caso dei fenomeni meteorologici, diverrebbe difficilissimo, se non addirittura impossibile, applicare con successo le equazioni; se viceversa le condizioni iniziali fossero troppo poche o nessuna, le equazioni darebbero soluzioni generiche che non dicono nulla.
Einstein partì dal presupposto che l’Universo fosse omogeneo e statico. Con il termine di «omogeneo» si intende che l’Universo potrebbe essere immaginato con la materia distribuita uniformemente come si trattasse di un gas le cui strutture materiali invece che da molecole e atomi siano rappresentate da galassie e stelle. Per quanto riguarda la «staticità», Einstein riteneva, come già Newton e come la maggior parte dei fisici e degli astronomi del suo tempo, che l’Universo fosse immobile ed eterno.
Ma, alle condizioni di cui sopra, le equazioni del campo gravitazionale non fornivano le soluzioni desiderate e pertanto lo stesso Einstein le modificò inserendovi il cosiddetto «termine cosmologico», un parametro ad hoc, tale da ottenere la soluzione statica cercata. Questo termine aggiuntivo avrebbe dovuto rappresentare una forza, di natura sconosciuta, in grado di bilanciare l’attrazione gravitazionale che, se avesse agito da sola, avrebbe fatto collassare l’Universo intero su sé stesso. Einstein in questo caso aveva torto e in seguito riconobbe egli stesso di aver commesso “la più grande sciocchezza” della sua carriera scientifica.
Nel 1922, il fisico sovietico Alexander Friedmann concluse che la soluzione delle equazioni di Einstein portava inevitabilmente al risultato di un Universo in equilibrio instabile. L’Universo doveva quindi cambiare col tempo, o espandendosi o contraendosi. Era un po’ come se gli individui bidimensionali, menzionati in precedenza, avessero scoperto non solo di vivere su una superficie curva, ma anche che tale superficie si andava lentamente modificando.
Friedmann dimostrò che se la materia presente nell’Universo fosse stata al di sotto di una certa quantità, l’Universo sarebbe stato «aperto» e destinato ad espandersi indefinitamente; se invece nell’Universo vi fosse stata materia in quantità superiore ad un certo valore minimo, esso sarebbe stato «chiuso» e destinato a contrarsi.
Quando Friedmann rese noti i suoi calcoli non vi era ancora la prova dell’espansione dell’Universo. Questa verrà solo sette anni più tardi quando, nel 1929, Edwin Hubble osservò il cosiddetto «red shift», cioè lo spostamento verso il rosso delle righe spettrali delle galassie lontane. Interpretati come effetto Doppler relativo alla luce, tali spostamenti indicano che le galassie sono in costante recessione.
Hubble era nato nel 1889 in una cittadina del Missouri ed era cresciuto un po’ lì e un po’ in un paese alla periferia di Chicago. Suo padre era un funzionario di successo nel campo delle assicurazioni e in conseguenza di ciò l’esistenza di Edwin fu sempre agiata. Il ragazzo godeva anche di una robusta costituzione fisica che gli consentì una vita da atleta forte e dotato. Era anche un tipo affascinante dalle belle fattezze che gli permettevano di avere successo fra i suoi coetanei. Come studente fu altrettanto capace e non ebbe problemi a guadagnarsi l’ammissione agli studi di fisica e astronomia presso l’Università di Chicago. Grazie ad una borsa di studio, si recò ad Oxford in Inghilterra dove rimase per tre anni e al ritorno si dedicò all’insegnamento in un liceo. Nel 1919, ormai trentenne, ottenne finalmente la laurea che gli consentì di trasferirsi in California per occupare un posto presso l’Osservatorio di Monte Wilson.
A quel tempo poco si sapeva dell’Universo che si pensava si esaurisse in una sola galassia: la Via Lattea. Tutto ciò che si osservava era ritenuto parte della stessa Via Lattea comprese alcune nuvolette di gas lontane e periferiche, mentre oggi si sa che quelle piccole nebulose erano galassie esse stesse, cioè isole di stelle che oggi si contano a miliardi. Nel decennio successivo Hubble affrontò due delle domande più fondamentali sull’Universo: quella riguardante la sua età e quella riguardante le sue dimensioni. Per rispondere alla prima domanda si avvalse della scoperta di una donna geniale, Henrietta Leavitt, la quale, utilizzando particolari stelle, dette variabili Cefeidi, come “candele standard”, dimostrò quanto erano lontane le galassie e con il “red shift” quanto fosse la velocità a cui le stesse galassie si allontanano.
L’effetto Doppler è un fenomeno che riguarda il suono e che venne descritto nel 1842 dal fisico austriaco Christian Doppler. Tutti noi abbiamo sperimentato che quando una sorgente sonora si avvicina emette un suono più acuto, quando si allontana emette un suono più grave rispetto a quando non si muove. Ciò dipende dal fatto che le onde sonore si «schiacciano» quando la sorgente è in avvicinamento e quindi la frequenza, cioè il numero di onde per unità di tempo ne risulta aumentato e il tono del suono diventa più alto; se la sorgente si allontana l’onda si «distende», la frequenza diminuisce, e di conseguenza il tono del suono si abbassa.
L’effetto Doppler può verificarsi per qualsiasi fenomeno di natura ondulatoria, quindi in particolare anche per la luce, che è una forma di energia che si propaga per onde.
Le osservazioni relative al red shift indicano anche che lo spostamento si accentua progressivamente con l’aumentare della distanza: ciò significa che quanto più una galassia è lontana da noi, tanto più velocemente viaggia. Da questa osservazione si potrebbe concludere che noi ci troviamo al centro dell’Universo ma, smentiti una prima volta dal modello geocentrico di Tolomeo, e successivamente dall’aver posto il sistema solare al centro della nostra Galassia, si preferì, in questo caso, adottare un atteggiamento di maggior prudenza e cercare di individuare una soluzione diversa.
Per farci un’idea della struttura dell’Universo quale si presenta alla luce della teoria della relatività e delle evidenze osservative riprendiamo l’analogia con la superficie sferica. Immaginiamo questa volta il nostro individuo bidimensionale sistemato su una superficie di grandi dimensioni come potrebbe essere la superficie della nostra Terra. Se questo individuo si guarda intorno vede una superficie piatta e molto uniforme (a parte le locali strutture di dettaglio) estendersi in tutte le direzioni, così che potrebbe farsi l’idea di essere al centro di qualche cosa. Ma non è così. La superficie di una sfera, infatti, non ha centro (si badi, la superficie non ha un centro, non così invece la sfera intera che nel suo interno ha un centro).
Allo stesso modo noi esseri tridimensionali, se ci guardiamo intorno, e osserviamo le galassie uniformemente distribuite in tutte le direzioni (a parte le locali strutture di dettaglio), abbiamo la sensazione di stare al centro di qualche cosa, ma è solo una sensazione: l’Universo, in realtà, non ha un centro. Da questo ragionamento Einstein ricavò il cosiddetto «principio cosmologico», cioè il concetto secondo il quale tutti gli osservatori, ovunque si trovino nell’Universo, dovrebbero osservare, intorno a loro, più o meno lo stesso scenario.
Il principio cosmologico rimane valido anche se l’Universo è in espansione. Per renderci conto di ciò immaginiamo ancora una volta la nostra sfera che ora si gonfia lentamente: la sua superficie si espande, e quindi le sue dimensioni aumentano con il tempo. Se ci trovassimo su un punto qualsiasi di essa, vedremmo intorno a noi tutti gli oggetti allontanarsi, e allontanarsi tanto più velocemente quanto più sono lontani da noi. In una situazione del genere si è tentati di concludere che ci si trova al centro di una qualche esplosione. Ma è solo un’illusione. Qualsiasi osservatore infatti, in qualunque punto della superficie sferica si trovasse, vedrebbe allontanarsi da sé tutti gli oggetti che gli stanno intorno.
Quello che vale per una superficie curva a due dimensioni vale anche per un Universo curvo a tre dimensioni: qualsiasi osservatore, sistemato in un punto qualsiasi, osserverebbe intorno a sé più o meno lo stesso tipo di distribuzione delle galassie e tutte queste galassie rivelerebbero pressappoco lo stesso tipo di recessione (minore quelle vicine, maggiore quelle lontane). Possiamo quindi concludere che non vi sono nell’Universo posizioni privilegiate. In verità l’Universo, come d’altra parte la superficie del pallone, avevano un centro ma solo all’origine, prima che iniziassero a gonfiarsi.
Nel 1948 il fisico russo naturalizzato americano George Gamow insieme a due suoi studenti, Ralph Alpher e Robert Hermann, sviluppò un modello relativo all’origine dell’Universo che già era stato proposto, qualche tempo prima, nelle sue linee generali, dall’abate G. Lemaître. Il ragionamento che portò Gamow alla formulazione del suo modello è il seguente: se le galassie oggi si allontanano fra loro, vuol dire che un tempo lontano esse erano molto più vicine di quanto non siano attualmente. Se si tornasse quindi abbastanza indietro nel tempo, si dovrebbe trovare tutta la materia e tutta la radiazione concentrata in uno spazio molto piccolo, forse addirittura in un punto.
Gamow era una persona molto spiritosa che rimase famoso, fra l’altro, per gli scherzi attuati ai danni dei suoi stessi colleghi. In occasione della pubblicazione della sua teoria sull’origine dell’Universo chiese al fisico Hans Bethe, che non aveva partecipato in alcun modo alla definizione delle nuove idee, di firmare l’articolo insieme a lui e ad Alpher. Dalle iniziali dei nomi dei tre scienziati, risultarono così le lettere greche α, β e γ: un’ottima sigla per un modello dell’origine dell’Universo.
Al modello, in seguito, venne dato il nome di «Big bang» (Grande scoppio), ma in senso spregiativo e ironico, dal fisico inglese Fred Hoyle, il quale nel frattempo insieme ai colleghi austriaci Hermann Bondi e Thomas Gold, aveva presentato una teoria alternativa a quella dell’Universo in evoluzione. Il modello di Hoyle, Bondi e Gold, prese il nome di «Modello di Universo in stato stazionario» e rappresentò l’ultimo disperato tentativo di salvare l’idea dell’immobilismo cosmico.
UN MODELLO ALTERNATIVO DI UNIVERSO
Per non cadere in contraddizione con i fondamenti primi della relatività generale – pensò Hoyle – l’aspetto dell’Universo su larga scala dovrebbe rimanere immutato non solo nello spazio, ma anche nel tempo. Il principio cosmologico dovrebbe quindi avere un carattere più generale, e cioè quello che lui chiamò «principio cosmologico perfetto».
I fautori del modello dello stato stazionario, pur convenendo sul fatto che l’Universo è in espansione, ciò nondimeno ritenevano che la densità della materia avrebbe dovuto rimanere costante nel tempo e quindi l’Universo intero presentarsi uniforme nello spazio e nel tempo. Pertanto, a mano a mano che le galassie si allontanano fra loro e lo spazio diviene sempre più vuoto, nuove galassie si sarebbero dovute formare per compensare il diradarsi delle vecchie.
La teoria dello stato stazionario prevede quindi una cosa a prima vista assurda: la creazione di materia dal nulla. Esisterebbe infatti, secondo Hoyle, un «campo creazionale» (in analogia con il «campo gravitazionale») generato dalla materia già esistente, in grado di creare nuova materia. Il ritmo con cui avverrebbe la creazione di nuova materia sarebbe tuttavia lentissimo e comunque tale da rendere impossibile il suo rilevamento.
Se quindi da un lato il modello stazionario pone il problema sconcertante della creazione di materia dal nulla, dall’altro ne evita altri, non meno imbarazzanti, come quello dell’origine. L’Universo, secondo Hoyle, non avrebbe quindi avuto inizio, né avrà fine: esso è sempre esistito ed esisterà per sempre.
Nella storia della scienza, tuttavia, è capitato spesso che le teorie più originali e convincenti siano state poi impietosamente demolite da osservazioni insignificanti e fortuite. Così avvenne anche per la teoria dello stato stazionario.
Nel 1965 due tecnici della società americana dei telefoni “Bell”, Arno Penzias e Robert Wilson, si imbatterono in un fastidioso sibilo che disturbava un nuovo tipo di telecomunicazione via satellite che essi stessi stavano sperimentando. Si trattava di un segnale radio di debole intensità proveniente da tutte le direzioni e captabile a qualunque ora del giorno e della notte. I due tecnici americani non si resero conto del significato della loro scoperta e tentarono di eliminare il segnale spurio ricorrendo ad una serie di perfezionamenti sulle apparecchiature riceventi.
Il segnale in realtà non era altro che la radiazione residua dell’esplosione primordiale, quella che in seguito venne chiamata «radiazione cosmica di fondo». Essa ha le caratteristiche di una radiazione ad onde corte (cioè è un’onda radio) corrispondente a quella che produrrebbe un oggetto che si trovasse alla temperatura di 3 K (cioè a 270 °C sotto lo zero). Questa radiazione era già stata prevista dallo stesso Gamow in base al suo modello e doveva rappresentare la «radiazione fossile» del Big bang, cioè il residuo delle altissime temperature raggiunte nelle prime fasi di vita dell’Universo, di quell’Universo che in seguito si sarebbe andato raffreddando lentamente e gradualmente per circa 15 miliardi di anni.
La radiazione cosmica di fondo non trovava invece giustificazione coerente all’interno del modello dello stato stazionario, che dovette pertanto essere abbandonato. In verità, la scoperta di Penzias e Wilson, per la quale i due tecnici ricevettero (forse non del tutto meritatamente) il premio Nobel, non fu l’unica evidenza osservativa contraria al modello dello stato stazionario. In precedenza, si era ad esempio osservato che le quasar, i corpi celesti di dimensioni di poco superiori a quelli delle stelle, ma che irradiano quantità colossali di energia, sono più abbondanti a grande che a piccola distanza. Ora, poiché guardare in lontananza corrisponde a guardare indietro nel tempo, si doveva concludere che l’aspetto dell’Universo di miliardi di anni fa era diverso dall’attuale, smentendo, in questo modo, il principio cosmologico perfetto al quale si era appellato Hoyle.
In definitiva, il modello che meglio riusciva ad inquadrare e a giustificare le osservazioni era proprio quello del Big bang. Anche questo modello, tuttavia, presentava una serie di carenze e di interrogativi di non poco conto. Uno di questi era, ad esempio, il problema relativo alla “singolarità”.
Risalendo indietro nel tempo, suggerisce il modello, si dovrebbe vedere l’Universo contrarsi e divenire sempre più caldo e sempre più denso. Si arriverebbe così ad un punto in cui le leggi della fisica classica non sarebbero più in grado di descriverne il comportamento.
Questo in condizioni di temperatura e densità eccezionali viene però descritto correttamente all’interno di nuove leggi fisiche, quelle inquadrate nella cosiddetta «fisica quantistica». In effetti, attraverso le leggi della fisica quantistica e attraverso le nuove scoperte relative all’impiego delle alte energie, oggi è possibile tentare la descrizione delle prime fasi di vita dell’Universo ed immaginarne anche una vera e propria creazione in senso fisico.
Certo, le risposte attualmente non sono né facili, né univoche; tuttavia il semplice fatto di aver cominciato ad affrontare anche questo problema in termini razionali, senza cioè dover fare ricorso ad interventi soprannaturali, rappresenta, già di per sé, un progresso rispetto agli atteggiamenti del passato.
Prof. Antonio Vecchia